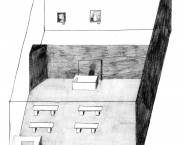26/04/2018
Osservatorio sul festival Ipercorpo: aperte le iscrizioni
20/03/2018
Direction Under 30: aperto il bando per candidarsi
20/03/2018
Planetarium ai festival di teatro-ragazzi
19/03/2018
Teatro e giovani generazioni: un incontro-dibattito a Castelfiorentino
10/11/2017
Performing Gender: gran finale a Bologna
08/11/2017
Master in Imprenditoria dello spettacolo 17-18, Università di Bologna
07/11/2017
Con occhi nudi: un itinerario al femminile
05/11/2017
Lettera 22. Premio giornalistico nazionale di critica teatrale under 36
04/09/2017
Cornice Aperta. Aperitivo con gli artisti del Festival Danza Urbana
19/05/2017
Maggio all'infanzia, dal 17 al 21 maggio a Bari
04/05/2017
Ivrea Cinquanta – Mezzo secolo di Nuovo Teatro in Italia 1967 – 2017. Genova, 5-7 maggio
29/03/2017
Un teatro in mezzo ai campi: 8 aprile con le Ariette
24/03/2017
''La formazione del nuovo pubblico'': un convegno sabato 25 marzo ad Albenga
28/02/2017
“Comizi d’amore”, open call per registi/drammaturghi e attori under 35 di Kepler-452
11/01/2017
La cultura nell'economia italiana: il 13 gennaio un convegno a Bologna
05/12/2016
Impertinente Festival: il teatro di figura a Parma, dal 7 all'11 dicembre
07/10/2016
Master in imprenditoria dello spettacolo, Bologna, anno accademico 2016-2017
23/09/2016
Infanzia e città a Pistoia, dal 24 settembre al 5 novembre 2016
03/09/2016
Dalla Cultura alla Scuola: ''Cosa abbiamo in Comune'', il 7 settembre a Bologna
31/08/2016
Electro Camp – International Platform for New Sounds and Dance, a Forte Marghera dal 7 all'11 settembre
«È una certa ostilità alla vita che mi ha condotto al teatro […] Io non provo quel desiderio di produrre vita sulle scene che ha attirato quasi tutti gli scrittori. Voglio esattamente il contrario: produrre qualcosa senza vita. Al teatro voglio strappare la vita».
Elfriede Jelinek
Lunghi monologhi di figure che non hanno apparentemente nessuna relazione tra loro, in un ininterrotto flusso verbale che non si ferma neppure dinanzi ai confini imposti dai singoli personaggi e dal conseguente cambio delle battute, bruschi accostamenti di frasi idiomatiche, calembour e virtuosismi sintattici, citazioni dai classici della letteratura e riferimenti alla più trita quotidianità, mancanza di una vera e propria azione: il teatro di Elfriede Jelinek sembra oltrepassare per radicalismo espressivo tutto ciò che la drammaturgia del secondo Novecento ha pure offerto in termini di sperimentazione linguistica, dalla asimmetria dei dialoghi di Beckett alla riduzione monologica dei lavori di Thomas Bernhard. Protagonista assoluta è la sfera del logos, che impone la sua terribile forza su ogni altro elemento, si tratti dei requisiti scenici, dell'intreccio o della stessa identità delle dramatis personae. Sul palcoscenico non si rappresentano più accadimenti, situazioni, costellazioni psicologiche, azioni o personaggi. A esibirsi è solo il linguaggio, o meglio la langue nel senso di de Saussure, gli schemi espressivi storicamente e socialmente determinati, dai quali nessuno può prescindere, il grande calderone delle frasi fatte, delle formulazioni preordinate, degli stereotipi e dei luoghi comuni, le scorie verbali della tradizione letteraria e religiosa, i «miti d'oggi», nella loro articolazione idiomatica. Ma non c'è, in questa virtuosa girandola di parole e proposizioni, l'idea lacaniana di un inconscio linguistico che da sé produce effetti magici e stranianti, mostrando nel suo fondo il luccichio del vero e dell'assoluto. Al contrario la drammatizzazione del logos è svolta con intento critico. Se la nostra langue è il nostro mondo, se il nostro mondo è dunque fatto di parole, mondo e parole mentono. Il teatro non è rivelazione dell'autentico, ma disvelamento della menzogna.
Nel suo trasgredire apertamente le norme fondamentali del genere – illusione scenica, dialogicità, centralità dell'azione –, la drammaturgia di Elfriede Jelinek si pone ai limiti della rappresentabilità e costituisce per questo anche una sfida per ogni regista e uomo di teatro, accolta peraltro con coraggio e passione sulle scene di lingua tedesca, a riprova dell'intatta vitalità di questo mondo. Eppure l'arte della parola della Jelinek è intrinsecamente teatrale, nel senso che essa è in primo luogo un'arte del mostrare e del mettere in scena. L'autrice non interviene nella tessitura drammaturgica con interventi diretti che rivelino il suo punto di vista. Al contrario, la stessa posizione autoriale è ironicamente inserita nel gioco delle parti e sottoposta al processo di drammatizzazione. I lavori teatrali di Elfriede Jelinek vogliono mostrare il mondo (compresa la stessa posizione di chi scrive), ma non vogliono dimostrare nulla. Non c'è riflessione dei personaggi sui loro comportamenti, perché personaggi e comportamenti si danno solo come maschere linguistiche, prive di spessore e di capacità di giudizio. La riflessione è affidata al solo spettatore. Mostrare è già un atto critico.
Subordinando il ruolo dei personaggi al fluire incessante della langue, la Jelinek trasforma le sue figure in voci, sdoppiandole dal corpo esibito sulla scena. L'autrice porta così alle estreme conseguenze un'idea a lungo coltivata dal teatro austriaco del Novecento e che ha probabilmente il suo iniziatore in Karl Kraus.
Con gli anni ciò che rimaneva di intreccio tradizionale nel teatro dell'autrice si è andato progressivamente sfaldando, insieme ad ogni riferimento a Brecht. In qualche modo, anzi, la drammaturgia di Elfriede Jelinek rappresenta un'inversione di marcia rispetto al teatro epico, nell'eliminazione sistematica di ogni commento autoriale, a favore dell'autonomia dell'oggettivazione scenica. Costante è tuttavia rimasto il gioco di riferimenti intertestuali, il richiamo a figure della letteratura e della storia, la ripresa di elementi tratti dall'attualità politica.
In molti drammi la Jelinek ripropone il paradigma, centrale in tanta letteratura del Novecento, dell'antitesi tra arte e vita, che però assume una singolare declinazione. L'assoluto dell'arte, sottratto alle imperfezioni dell'esistenza, diviene una condizione di non-vita, di morte. Nella loro artificiosità, nel loro ripetere parole dette da altri, le figure di tutti i drammi della Jelinek sono figure che non hanno una vita reale. Le loro voci sono postume.
Certamente il teatro di Elfriede Jelinek resta, nella sua estrema provocazione, una sfida per tutti i destinatari coinvolti: registi, attori, traduttori e naturalmente lettori. Ma resta, in primo luogo, una sfida per i nostri tempi.
Luigi Reitani
Il presente saggio è apparso in forma più estesa nell’introduzione al volume Sport. Una pièce - Fa niente. Una piccola trilogia della morte (Ubulibri, 2005). Per gentile concessione dell'autore.
18 luglio 2018
Sansepolcro, Kilowatt Festival
A Porte Aperte. Un convegno sui processi creativi tra sguardi, ricerche, residenze
30 maggio 2018
Bologna
Presentazione cd audio Crescere spettatori
Baci dalla provincia
Note, appunti, cronache, recensioni sulla scena teatrale italiana e internazionale
Interviste
Conversazioni sulla scena contemporanea italiana e internazionale
La qualita' dell'aria
Approfondimenti, riflessioni, spunti: questioni che ci stanno a cuore partendo dalle opere per arrivare ai "teatri", e che vorremmo condividere
Scritture, drammaturgie
Note, appunti, percorsi sul panorama editoriale attento alle arti sceniche
Radio
Raccogliamo in questa sezione alcune delle puntate radiofoniche dal vivo curate da Altre Velocità
Doppiozero - Teatri presenti
Approfondimenti, ritratti, recensioni, interviste per Doppiozero, rivista diretta da Marco Belpoliti. In questo spazio raccogliamo gli articoli a un mese di distanza dalla loro uscita
La parola attore
Cosa chiediamo a un attore, a una attrice? Cosa chiedono loro a noi? Scritti d'attore e di attrici originali per Altre Velocità
marzo-maggio 2018
Planetarium
Osservatorio sul teatro ragazzi
14 - 22 ottobre 2017
Vie Festival 2017
Laboratorio di critica e giornalismo
giugno 2017
Futuri Maestri
Laboratorio Futuri giornalisti
28-31 ottobre 2016
Crisalide
Perché passi un po' di caos libero e ventoso
ottobre 2016
Vie Festival 2016
Arti sceniche internazionali e italiane
22 settembre - 2 ottobre 2016
Contemporanea Festival 2016
Le arti della scena
ottobre 2015
Vie Festival 2015
Arti sceniche internazionali e italiane
1-4 ottobre 2015
Crisalide
Non è successo niente, è ciò che stiamo diventando
25 settembre - 4 ottobre 2015
Contemporanea Festival 2015
Le arti della scena
Febbraio - aprile 2015
Nelle pieghe del Corpo
Virgilio Sieni, Bologna
ottobre 2014 - marzo 2015
Festival Focus Jelinek
Festival per città
9-25 ottobre 2014
Vie Festival 2014 Modena___Emilia
Arti sceniche internazionali
10 - 20 luglio 2014
Santarcangelo · 14
Festival internazionale del teatro in piazza
12 - 21 luglio 2013
Santarcangelo · 13
Festival Internazionale del Teatro in Piazza
aprile 2013
Pinocchio della non-scuola
Immagini a cura di Osservatorio Fotografico, note a margine su Pinocchio
5-13 ottobre 2012
Tempo Reale Festival
Ricerche musicali contemporanee
14 - 23 luglio 2012
SANTARCANGELO •12
Festival internazionale del teatro in piazza
Primavera 2012
Vie Scena Contemporanea Festival
Arti sceniche internazionali
Marzo 2012
BilBolbul 2012
fumetto, illustrazione, disegno
ottobre 2011
Vie Scena Contemporanea Festival
Teatro internazionale a Modena, Carpi, Vignola e limitrofi
Settembre 2011
Arca Puccini - Musica per combinazione
Rock indipendente italiano e internazionale
febbraio 2015
Radio Zolfo - Rafael Spregelburd
Con Rafael Spregelburd e Silvia Mei
febbraio 2015
Radio Zolfo - Interpretare Elfriede Jelinek
con Elena Bucci Fiorenza Menni / Ateliersi Anna Amadori e Olga Durano / Teatri di Vita e con Elena Di Gioia
maggio 2013
Radio Zolfo #festa13
Con Cristina D'Alberto, Marco Valerio Amico, Chiara Lagani. Showcase di Mangiacassette
aprile 2013
Radio Zolfo Focus Melquiot
Con Anna Amadori, showcase di Guido Sodo
2012
Barokthegreat, Gli Incauti, Menoventi, Orthographe
CODA - Teatri del presente
2010
Disegni e parole dal teatro di Fanny & Alexander, Motus, Chiara Guidi/Societas Raffaello Sanzio, Teatrino Clandestino
UN COLPO
2009
Azione e immaginazione da Cantieri a Anticorpi XL
Giovane Danza d'Autore