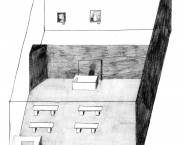NEWS
26/04/2018
Osservatorio sul festival Ipercorpo: aperte le iscrizioni
20/03/2018
Direction Under 30: aperto il bando per candidarsi
20/03/2018
Planetarium ai festival di teatro-ragazzi
19/03/2018
Teatro e giovani generazioni: un incontro-dibattito a Castelfiorentino
10/11/2017
Performing Gender: gran finale a Bologna
08/11/2017
Master in Imprenditoria dello spettacolo 17-18, Università di Bologna
07/11/2017
Con occhi nudi: un itinerario al femminile
05/11/2017
Lettera 22. Premio giornalistico nazionale di critica teatrale under 36
04/09/2017
Cornice Aperta. Aperitivo con gli artisti del Festival Danza Urbana
19/05/2017
Maggio all'infanzia, dal 17 al 21 maggio a Bari
04/05/2017
Ivrea Cinquanta – Mezzo secolo di Nuovo Teatro in Italia 1967 – 2017. Genova, 5-7 maggio
29/03/2017
Un teatro in mezzo ai campi: 8 aprile con le Ariette
24/03/2017
''La formazione del nuovo pubblico'': un convegno sabato 25 marzo ad Albenga
28/02/2017
“Comizi d’amore”, open call per registi/drammaturghi e attori under 35 di Kepler-452
11/01/2017
La cultura nell'economia italiana: il 13 gennaio un convegno a Bologna
05/12/2016
Impertinente Festival: il teatro di figura a Parma, dal 7 all'11 dicembre
07/10/2016
Master in imprenditoria dello spettacolo, Bologna, anno accademico 2016-2017
23/09/2016
Infanzia e città a Pistoia, dal 24 settembre al 5 novembre 2016
03/09/2016
Dalla Cultura alla Scuola: ''Cosa abbiamo in Comune'', il 7 settembre a Bologna
31/08/2016
Electro Camp – International Platform for New Sounds and Dance, a Forte Marghera dal 7 all'11 settembre
26/04/2018
Osservatorio sul festival Ipercorpo: aperte le iscrizioni
20/03/2018
Direction Under 30: aperto il bando per candidarsi
20/03/2018
Planetarium ai festival di teatro-ragazzi
19/03/2018
Teatro e giovani generazioni: un incontro-dibattito a Castelfiorentino
10/11/2017
Performing Gender: gran finale a Bologna
08/11/2017
Master in Imprenditoria dello spettacolo 17-18, Università di Bologna
07/11/2017
Con occhi nudi: un itinerario al femminile
05/11/2017
Lettera 22. Premio giornalistico nazionale di critica teatrale under 36
04/09/2017
Cornice Aperta. Aperitivo con gli artisti del Festival Danza Urbana
19/05/2017
Maggio all'infanzia, dal 17 al 21 maggio a Bari
04/05/2017
Ivrea Cinquanta – Mezzo secolo di Nuovo Teatro in Italia 1967 – 2017. Genova, 5-7 maggio
29/03/2017
Un teatro in mezzo ai campi: 8 aprile con le Ariette
24/03/2017
''La formazione del nuovo pubblico'': un convegno sabato 25 marzo ad Albenga
28/02/2017
“Comizi d’amore”, open call per registi/drammaturghi e attori under 35 di Kepler-452
11/01/2017
La cultura nell'economia italiana: il 13 gennaio un convegno a Bologna
05/12/2016
Impertinente Festival: il teatro di figura a Parma, dal 7 all'11 dicembre
07/10/2016
Master in imprenditoria dello spettacolo, Bologna, anno accademico 2016-2017
23/09/2016
Infanzia e città a Pistoia, dal 24 settembre al 5 novembre 2016
03/09/2016
Dalla Cultura alla Scuola: ''Cosa abbiamo in Comune'', il 7 settembre a Bologna
31/08/2016
Electro Camp – International Platform for New Sounds and Dance, a Forte Marghera dal 7 all'11 settembre
FOCUS SU ORIZA HIRATA SEINENDAN > Intervista a Oriza Hirata
Classe 1962, Oriza Hirata ha iniziato a lavorare giovanissimo come drammaturgo, e oggi la sua compagnia, Seinendan, è tra i nomi di punta della scena contemporanea giapponese. L’arte di Hirata e la sua scrittura sono conosciuti ben oltre gli steccati del mondo teatrale, e la sua compagnia è ormai una presenza fissa in Europa, soprattutto in Francia. In una lunga conversazione con l’osservatorio critico, Hirata ha raccontato le origini della sua carriera e le coordinate del suo metodo che cerca di inventare, attraverso la colloquialità, delle forme che restituiscano la lingua giapponese reale al di là degli stereotipi linguistici dei drammi europei.
Come si è avvicinato al teatro? E come nasce la compagnia Seinendan?
Sono nato in una famiglia di artisti, mio padre faceva teatro, vivevo in quell’ambiente già prima di diventare famoso. Quando mi chiedono di raccontare la mia vita mi piace cominciare dal viaggio in bici intorno al mondo che ho fatto a sedici anni, perché il mio debutto da scrittore, a diciotto anni, è stato proprio il diario di quel viaggio. Dopo quella prima pubblicazione ho sentito di non essere portato per le cose così legate alla realtà e mi sono avvicinato al mondo del teatro. All’università non ho scelto ambiti artistici, ma ho formato una compagnia teatrale. All’epoca non pensavo che potesse durare così tanto: era l’hobby di un gruppo di studenti... Ma sono passati più di trent’anni! Il mio sogno, in realtà, era fare lo scrittore. Sapevo che non ero molto adatto a fare il regista, così per lo più scrivevo i testi. Ogni tanto mi cimentavo nella regia ma i miei spettacoli venivano troppo seri, enigmatici e spesso troppo drammatici: non erano apprezzati dai miei amici che mi hanno consigliato di restare drammaturgo. Un’altra esperienza molto importante per la mia formazione di scrittore è stato il soggiorno in Corea. Io sono nato in uno stato democratico, in una città cosmopolita come Tokyo, quindi andare in Corea significava immettersi in una situazione completamente diversa. Quel soggiorno mi ha aiutato a scrivere in maniera più umana: prima scrivevo cose ideologiche o utopiche, invece lì mi sono avvicinato alla vita vera. Oltretutto vivere in Corea e studiare la lingua coreana mi hanno aiutato a comprendere meglio la lingua giapponese: ho cominciato a vedere la lingua giapponese e ad analizzarla come un oggetto esterno. Dopo questo soggiorno sono tornato in Giappone e più o meno dopo due anni ho ripreso a occuparmi della regia teatrale. La teoria attuale l’ho formata in circa tre anni di lavoro. Il periodo più faticoso non è stato quello in cui ho stabilito la teoria, ma quello in cui ho dovuto applicarla.
Quali difficoltà pratiche ha trovato nell’applicare le sue teorie?
Sentivo di aver fatto una teoria giusta, ma non ne capivo l’utilità. Nell’89 ho scritto un testo, Cittadini di Seoul, ambientato nell’epoca coloniale, quando la Corea era una colonia giapponese; lo spettacolo racconta una giornata qualsiasi di una famiglia giapponese che viveva in Corea. Non vediamo nessun elemento aggressivo, come la presenza militare o la corruzione politica, e ci sono poche battute che mostrano quanto i giapponesi considerassero inferiori i coreani. Ma è proprio in questo contesto di assoluto realismo che emerge l’aggressività di quella situazione. Questo spettacolo per me è stato la dimostrazione che la mia teoria del super-realismo poteva essere applicata.
Il suo metodo ha lo scopo di superare gli stereotipi teatrali importati dall’occidente. Che rapporto ha questa impostazione con la lingua?
In Giappone la musica e l’arte sono materie scolastiche. Quando abbiamo iniziato ad importare musica dall’occidente, quindi, lo abbiamo fatto con una certa cautela ed è stato possibile creare una nuova forma di musica e di arte giapponese basate sullo stile occidentale. All’inizio c’è stato anche un processo di imitazione, ma già nell’atto di copiare sceglievamo sonorità più simili alle nostre: per esempio la musica giapponese tradizionale ha più o meno la stessa scala delle musiche popolari scozzesi o irlandesi. Per il teatro non è stato così. L’importazione di spettacoli occidentali è avvenuta dal 1920 in poi tramite i privati, non era quindi un’importazione organizzata. Gli studenti andavano a vedere gli spettacoli al teatro Odeon, l’unico teatro che faceva spettacoli occidentali tradotti in giapponese, e copiavano le battute e i dialoghi per poi andare a riprodurli in maniera identica. La cosa buffa è che per apparire occidentali mettevano agli attori parrucche di capelli biondi e nasi finti: cercavano di copiare persino le sembianze fisiche. Come sapete noi giapponesi siamo bravissimi a copiare. Ne è un esempio Yukio Mishima: lui è riuscito a copiare gli scrittori occidentali ma scrivendo in lingua giapponese. I testi di Mishima sono dei capolavori perfetti, ma nessun giapponese parlerebbe mai nel modo da lui descritto. Io ho cercato una tensione verso la lingua giapponese parlata, cercando di rispettare anche l’ordine delle parole, la costruzione della frase così come suona quando è detta. Una volta lessi su un manuale di recitazione che per porre l’attenzione su una parola della frase bisogna enfatizzarla. Se dicendo “questo è un bicchiere” vuoi portare l’attenzione sul fatto che il bicchiere è questo e non un altro devi dire “questo è un bicchiere”; se invece vuoi dare più attenzione al fatto che è un bicchiere e non un’altra cosa dici “questo è un bicchiere”. Quindi la tecnica è porre l’accento sulla cosa che più interessa. In giapponese non funziona così: si può anche ripetere tante volte una parola se la vuoi accentuare (“questo è un bicchiere bicchiere bicchiere”). La lingua giapponese è abbastanza piatta nelle intonazioni o negli accenti, mentre le lingue occidentali sono più “movimentate”. Quando hanno importato il teatro occidentale in Giappone, oltre ad aver tradotto mantenendo lo stile parlato occidentale, hanno anche applicato le metodologie della recitazione e della scrittura ad esso legate: il risultato è così innaturale da non essere credibile. Per fare uno spettacolo realistico, per raccontare la vita vera dei giapponesi, non potevamo utilizzare quel linguaggio.
In che rapporto è il suo lavoro con i generi tradizionali del teatro giapponese come il Nō e il Kabuki?
Sono forme di teatro molto diverse dalla mia, ma soprattutto usano linguaggi molto lontani, linguaggi medievali, antichi. Quindi se mi chiedi cosa ho introdotto di quella tradizione nel mio teatro devo dirti “niente”. Sicuramente però ho preso spunto dai testi tradizionali: nel teatro tradizionale è importantissimo come finisce la battuta precedente per l’attacco della battuta successiva; oppure nel teatro del Nō, c’è sempre una presenza, un osservatore sul palcoscenico, oltre all’attore che recita. In Tokyo notes si nota molto bene come anche per me debba esserci sempre una presenza in più, un osservatore, rispetto a chi è impegnato nella conversazione: questo deriva dal teatro Nō.
Lei ha realizzato, con l’università di Osaka, il progetto Robot-Human Theatre: laboratorio e spettacolo per attori robot. Che fine fa l’attore?
Se devo dire la verità, sono sicuro che sostituire al cento per cento gli attori vivi con dei robot non sarà fattibile, almeno prima di cento anni. Non è una cosa impossibile, ma già il solo fatto che sia una cosa teoricamente possibile ci fa riflettere su cosa sia il teatro e su cosa sia il lavoro dell’attore. Quest’elemento diverso può aiutare la comprensione del teatro, offrendo un confronto. Nel progetto Robot-Human Theatre, che porterò a Palermo il prossimo settembre, uso dei robot non molto raffinati. Eppure questi robot, abbastanza semplici, vengono percepiti dalla maggior parte del pubblico come “vivi”, pieni di sentimenti, come se avessero un cuore. Non penso sia una cosa così strana: succede anche che il pubblico immagini cattivo un attore che semplicemente interpreta il ruolo di un uomo malvagio. Quindi una parte della mia ricerca è proprio indirizzata a questo: che la regia possa essere così precisa e ben strutturata da far credere che anche dei robot abbiano un’anima. Allora quanto il lavoro dell’attore è attivo e quanto invece è meccanico? Ovviamente preferisco un attore bravo, capace ed espressivo. Un attore bravo ha una capacità che non si può sostituire con niente, né con la tecnologia, né con la regia. In Tokio notes c’è un personaggio molto importante, la moglie tradita che rimane spesso con la cognata: quel ruolo lì è stato scritto per un’attrice specifica, che poi ha portato avanti il ruolo per quindici anni e nessuno ha mai pensato che si potesse sostituire con un’altra attrice. Quando a quarantacinque anni rimase incinta, e non poté più andare in scena, è stata sostituita con la ragazza che avete visto in scena a Santarcangelo. All’inizio cambiare l’attrice ha creato uno scompiglio totale: dalle difficoltà create a causa della sua diversità si capisce quanto la presenza di un attore sia fondamentale. Però dopo un anno la sua presenza è diventata normale e oggi nessuno potrebbe immaginare un’attrice diversa per quel ruolo. In qualche modo il lavoro dell’attore è anche un po’ triste: per quanto sia bravo, per quanto si creda indispensabile, in realtà è sostituibile, qualsiasi attore è sostituibile alla fine.
Parliamo del suo metodo. Come nascono i giochi e gli esercizi che propone nei suoi workshop? Cambiano da paese a paese?
Prendo spunti da diverse cose, com’è ovvio, ma fondamentalmente sono tutti giochi o metodi creati da me. Originariamente questo tipo di giochi di società è stato sviluppato nei paesi anglosassoni. Io ho fatto una lunga ricerca, ho studiato a fondo questi giochi inglesi, e ne conosco parecchi; però davvero pochi si possono adattare e utilizzare in Giappone perché hanno comunque un’impostazione occidentale. Quando devo organizzare un laboratorio all’estero, la metodologia rimane la stessa, ma applico piccole variazioni di contenuto. Perché alcuni esempi funzionano bene in Giappone e non in altri luoghi. Quindi cerco di stare attento negli esempi, nei doppi sensi, nelle ironie e nelle semplificazioni: quando sono all’estero cerco di semplificare il più possibile. Per quanto riguarda la risposta dei partecipanti a questo metodo le differenze non dipendono dalla nazionalità dei partecipanti, ma dal loro grado di formazione.
Nel suo metodo lei si riferisce ad ambientazioni particolari: quello che definisce un semi-pubblic place, un posto dove non c’è una totale intimità ma neanche la codificazione del comportamento in pubblico. Perché?
Per capire l’importanza di questi aspetti bisogna tenere presente le peculiarità della cultura giapponese e la differenza tra dialogo e conversazione. La conversazione è un libero scambio di parole, delle chiacchere diciamo; il dialogo, invece, è una discussione, uno scambio di opinioni attraverso il confronto. Il popolo giapponese non è abituato a relazionarsi attraverso il dialogo, a confrontarsi. Spesso quando un giapponese capisce che l’altra persona ha un’altra opinione rispetto alla sua, non si mette a discutere, evita sempre di parlarne, piuttosto cambia l’argomento. Solo che il teatro contemporaneo è basato sulle discussioni, non è una narrazione, ma una discussione pubblica. Un’altra caratteristica della comunicazione dei giapponesi di oggi è che non si discute a lungo su uno stesso argomento: le persone si incontrano, scambiano due parole e poi si separano. Questo è molto chiaro in Tokyo notes dove lo spettacolo viene costruito proprio sulle sovrapposizioni di tanti scambi, di tante conversazioni. Il dialogo, lo scambio di opinioni, è una cosa fondamentale per il mondo democratico: sin dall’antica Grecia il teatro, la democrazia e il dialogo erano un’unica cosa. Il Giappone non è ancora un paese democratico al cento per cento: è stato governato per sessant’anni dalla destra, e ora serve un grande sforzo educativo, una formazione che parta dall’infanzia, che insegni ai bambini e ai ragazzi a esprimersi. Per questo, ad esempio, porto avanti anche un lavoro con i bambini.
Il suo teatro ha anche una dimensione pedagogica?
La pedagogia è pedagogia. La creazione di uno spettacolo teatrale è tutta un’altra cosa. Io considero l’arte e l’educazione due cose diverse, ben distinte, delle volte addirittura opposte. L’arte non fa parte dell’educazione, ma fa parte della società, di un certo ambiente per un certo periodo di tempo.
Ma l’arte può influire sulla realtà?
Io considero l’arte assolutamente superiore alla politica e all’economia: l’arte è una cosa immensa, perché può essere utile alla società. Può servire alla sua stessa epoca, ma potrebbe essere utile anche per un’altra epoca, in un altro luogo. In Giappone a marzo c’è stato un terremoto e lo tsunami. Ci sono stati eventi o iniziative artistiche per risollevare il morale dei terremotati. Al contrario a Tokyo, che è una città meno colpita, hanno annullato spettacoli e concerti per essere solidali alla sofferenza della parte settentrionale del Giappone. Ma se noi smettiamo di creare adesso, le persone sofferenti come potranno ricevere supporto, oggi o fra cento anni? Io credo che l’opera di un artista sia dedicata alle persone che vivono esattamente dall’altra parte del mondo tra cento anni. Però quando la mia arte sarà utile alla società io non ci sarò più, quindi il compenso devo riceverlo adesso: ecco perché non si possono diminuire i fondi per la cultura.
(ha collaborato Cinzia Toscano)
Bernardo Brogi
AGENDA
18 luglio 2018
Sansepolcro, Kilowatt Festival
A Porte Aperte. Un convegno sui processi creativi tra sguardi, ricerche, residenze
30 maggio 2018
Bologna
Presentazione cd audio Crescere spettatori
18 luglio 2018
Sansepolcro, Kilowatt Festival
A Porte Aperte. Un convegno sui processi creativi tra sguardi, ricerche, residenze
30 maggio 2018
Bologna
Presentazione cd audio Crescere spettatori
TEATRI D'OGGI
Baci dalla provincia
Note, appunti, cronache, recensioni sulla scena teatrale italiana e internazionale
Interviste
Conversazioni sulla scena contemporanea italiana e internazionale
La qualita' dell'aria
Approfondimenti, riflessioni, spunti: questioni che ci stanno a cuore partendo dalle opere per arrivare ai "teatri", e che vorremmo condividere
Scritture, drammaturgie
Note, appunti, percorsi sul panorama editoriale attento alle arti sceniche
Radio
Raccogliamo in questa sezione alcune delle puntate radiofoniche dal vivo curate da Altre Velocità
Doppiozero - Teatri presenti
Approfondimenti, ritratti, recensioni, interviste per Doppiozero, rivista diretta da Marco Belpoliti. In questo spazio raccogliamo gli articoli a un mese di distanza dalla loro uscita
La parola attore
Cosa chiediamo a un attore, a una attrice? Cosa chiedono loro a noi? Scritti d'attore e di attrici originali per Altre Velocità
Baci dalla provincia
Note, appunti, cronache, recensioni sulla scena teatrale italiana e internazionale
Interviste
Conversazioni sulla scena contemporanea italiana e internazionale
La qualita' dell'aria
Approfondimenti, riflessioni, spunti: questioni che ci stanno a cuore partendo dalle opere per arrivare ai "teatri", e che vorremmo condividere
Scritture, drammaturgie
Note, appunti, percorsi sul panorama editoriale attento alle arti sceniche
Radio
Raccogliamo in questa sezione alcune delle puntate radiofoniche dal vivo curate da Altre Velocità
Doppiozero - Teatri presenti
Approfondimenti, ritratti, recensioni, interviste per Doppiozero, rivista diretta da Marco Belpoliti. In questo spazio raccogliamo gli articoli a un mese di distanza dalla loro uscita
La parola attore
Cosa chiediamo a un attore, a una attrice? Cosa chiedono loro a noi? Scritti d'attore e di attrici originali per Altre Velocità
FESTIVAL
marzo-maggio 2018
Planetarium
Osservatorio sul teatro ragazzi
14 - 22 ottobre 2017
Vie Festival 2017
Laboratorio di critica e giornalismo
giugno 2017
Futuri Maestri
Laboratorio Futuri giornalisti
28-31 ottobre 2016
Crisalide
Perché passi un po' di caos libero e ventoso
ottobre 2016
Vie Festival 2016
Arti sceniche internazionali e italiane
22 settembre - 2 ottobre 2016
Contemporanea Festival 2016
Le arti della scena
ottobre 2015
Vie Festival 2015
Arti sceniche internazionali e italiane
1-4 ottobre 2015
Crisalide
Non è successo niente, è ciò che stiamo diventando
25 settembre - 4 ottobre 2015
Contemporanea Festival 2015
Le arti della scena
Febbraio - aprile 2015
Nelle pieghe del Corpo
Virgilio Sieni, Bologna
ottobre 2014 - marzo 2015
Festival Focus Jelinek
Festival per città
9-25 ottobre 2014
Vie Festival 2014 Modena___Emilia
Arti sceniche internazionali
10 - 20 luglio 2014
Santarcangelo · 14
Festival internazionale del teatro in piazza
12 - 21 luglio 2013
Santarcangelo · 13
Festival Internazionale del Teatro in Piazza
aprile 2013
Pinocchio della non-scuola
Immagini a cura di Osservatorio Fotografico, note a margine su Pinocchio
5-13 ottobre 2012
Tempo Reale Festival
Ricerche musicali contemporanee
14 - 23 luglio 2012
SANTARCANGELO •12
Festival internazionale del teatro in piazza
Primavera 2012
Vie Scena Contemporanea Festival
Arti sceniche internazionali
Marzo 2012
BilBolbul 2012
fumetto, illustrazione, disegno
ottobre 2011
Vie Scena Contemporanea Festival
Teatro internazionale a Modena, Carpi, Vignola e limitrofi
Settembre 2011
Arca Puccini - Musica per combinazione
Rock indipendente italiano e internazionale
marzo-maggio 2018
Planetarium
Osservatorio sul teatro ragazzi
14 - 22 ottobre 2017
Vie Festival 2017
Laboratorio di critica e giornalismo
giugno 2017
Futuri Maestri
Laboratorio Futuri giornalisti
28-31 ottobre 2016
Crisalide
Perché passi un po' di caos libero e ventoso
ottobre 2016
Vie Festival 2016
Arti sceniche internazionali e italiane
22 settembre - 2 ottobre 2016
Contemporanea Festival 2016
Le arti della scena
ottobre 2015
Vie Festival 2015
Arti sceniche internazionali e italiane
1-4 ottobre 2015
Crisalide
Non è successo niente, è ciò che stiamo diventando
25 settembre - 4 ottobre 2015
Contemporanea Festival 2015
Le arti della scena
Febbraio - aprile 2015
Nelle pieghe del Corpo
Virgilio Sieni, Bologna
ottobre 2014 - marzo 2015
Festival Focus Jelinek
Festival per città
9-25 ottobre 2014
Vie Festival 2014 Modena___Emilia
Arti sceniche internazionali
10 - 20 luglio 2014
Santarcangelo · 14
Festival internazionale del teatro in piazza
12 - 21 luglio 2013
Santarcangelo · 13
Festival Internazionale del Teatro in Piazza
aprile 2013
Pinocchio della non-scuola
Immagini a cura di Osservatorio Fotografico, note a margine su Pinocchio
5-13 ottobre 2012
Tempo Reale Festival
Ricerche musicali contemporanee
14 - 23 luglio 2012
SANTARCANGELO •12
Festival internazionale del teatro in piazza
Primavera 2012
Vie Scena Contemporanea Festival
Arti sceniche internazionali
Marzo 2012
BilBolbul 2012
fumetto, illustrazione, disegno
ottobre 2011
Vie Scena Contemporanea Festival
Teatro internazionale a Modena, Carpi, Vignola e limitrofi
Settembre 2011
Arca Puccini - Musica per combinazione
Rock indipendente italiano e internazionale
PODCAST
febbraio 2015
Radio Zolfo - Rafael Spregelburd
Con Rafael Spregelburd e Silvia Mei
febbraio 2015
Radio Zolfo - Interpretare Elfriede Jelinek
con Elena Bucci Fiorenza Menni / Ateliersi Anna Amadori e Olga Durano / Teatri di Vita e con Elena Di Gioia
maggio 2013
Radio Zolfo #festa13
Con Cristina D'Alberto, Marco Valerio Amico, Chiara Lagani. Showcase di Mangiacassette
aprile 2013
Radio Zolfo Focus Melquiot
Con Anna Amadori, showcase di Guido Sodo
febbraio 2015
Radio Zolfo - Rafael Spregelburd
Con Rafael Spregelburd e Silvia Mei
febbraio 2015
Radio Zolfo - Interpretare Elfriede Jelinek
con Elena Bucci Fiorenza Menni / Ateliersi Anna Amadori e Olga Durano / Teatri di Vita e con Elena Di Gioia
maggio 2013
Radio Zolfo #festa13
Con Cristina D'Alberto, Marco Valerio Amico, Chiara Lagani. Showcase di Mangiacassette
aprile 2013
Radio Zolfo Focus Melquiot
Con Anna Amadori, showcase di Guido Sodo
PUBBLICAZIONI
2012
Barokthegreat, Gli Incauti, Menoventi, Orthographe
CODA - Teatri del presente
2010
Disegni e parole dal teatro di Fanny & Alexander, Motus, Chiara Guidi/Societas Raffaello Sanzio, Teatrino Clandestino
UN COLPO
2009
Azione e immaginazione da Cantieri a Anticorpi XL
Giovane Danza d'Autore
2012
Barokthegreat, Gli Incauti, Menoventi, Orthographe
CODA - Teatri del presente
2010
Disegni e parole dal teatro di Fanny & Alexander, Motus, Chiara Guidi/Societas Raffaello Sanzio, Teatrino Clandestino
UN COLPO
2009
Azione e immaginazione da Cantieri a Anticorpi XL
Giovane Danza d'Autore