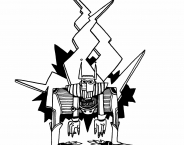NEWS
26/04/2018
Osservatorio sul festival Ipercorpo: aperte le iscrizioni
20/03/2018
Direction Under 30: aperto il bando per candidarsi
20/03/2018
Planetarium ai festival di teatro-ragazzi
19/03/2018
Teatro e giovani generazioni: un incontro-dibattito a Castelfiorentino
10/11/2017
Performing Gender: gran finale a Bologna
08/11/2017
Master in Imprenditoria dello spettacolo 17-18, Università di Bologna
07/11/2017
Con occhi nudi: un itinerario al femminile
05/11/2017
Lettera 22. Premio giornalistico nazionale di critica teatrale under 36
04/09/2017
Cornice Aperta. Aperitivo con gli artisti del Festival Danza Urbana
19/05/2017
Maggio all'infanzia, dal 17 al 21 maggio a Bari
04/05/2017
Ivrea Cinquanta – Mezzo secolo di Nuovo Teatro in Italia 1967 – 2017. Genova, 5-7 maggio
29/03/2017
Un teatro in mezzo ai campi: 8 aprile con le Ariette
24/03/2017
''La formazione del nuovo pubblico'': un convegno sabato 25 marzo ad Albenga
28/02/2017
“Comizi d’amore”, open call per registi/drammaturghi e attori under 35 di Kepler-452
11/01/2017
La cultura nell'economia italiana: il 13 gennaio un convegno a Bologna
05/12/2016
Impertinente Festival: il teatro di figura a Parma, dal 7 all'11 dicembre
07/10/2016
Master in imprenditoria dello spettacolo, Bologna, anno accademico 2016-2017
23/09/2016
Infanzia e città a Pistoia, dal 24 settembre al 5 novembre 2016
03/09/2016
Dalla Cultura alla Scuola: ''Cosa abbiamo in Comune'', il 7 settembre a Bologna
31/08/2016
Electro Camp – International Platform for New Sounds and Dance, a Forte Marghera dal 7 all'11 settembre
26/04/2018
Osservatorio sul festival Ipercorpo: aperte le iscrizioni
20/03/2018
Direction Under 30: aperto il bando per candidarsi
20/03/2018
Planetarium ai festival di teatro-ragazzi
19/03/2018
Teatro e giovani generazioni: un incontro-dibattito a Castelfiorentino
10/11/2017
Performing Gender: gran finale a Bologna
08/11/2017
Master in Imprenditoria dello spettacolo 17-18, Università di Bologna
07/11/2017
Con occhi nudi: un itinerario al femminile
05/11/2017
Lettera 22. Premio giornalistico nazionale di critica teatrale under 36
04/09/2017
Cornice Aperta. Aperitivo con gli artisti del Festival Danza Urbana
19/05/2017
Maggio all'infanzia, dal 17 al 21 maggio a Bari
04/05/2017
Ivrea Cinquanta – Mezzo secolo di Nuovo Teatro in Italia 1967 – 2017. Genova, 5-7 maggio
29/03/2017
Un teatro in mezzo ai campi: 8 aprile con le Ariette
24/03/2017
''La formazione del nuovo pubblico'': un convegno sabato 25 marzo ad Albenga
28/02/2017
“Comizi d’amore”, open call per registi/drammaturghi e attori under 35 di Kepler-452
11/01/2017
La cultura nell'economia italiana: il 13 gennaio un convegno a Bologna
05/12/2016
Impertinente Festival: il teatro di figura a Parma, dal 7 all'11 dicembre
07/10/2016
Master in imprenditoria dello spettacolo, Bologna, anno accademico 2016-2017
23/09/2016
Infanzia e città a Pistoia, dal 24 settembre al 5 novembre 2016
03/09/2016
Dalla Cultura alla Scuola: ''Cosa abbiamo in Comune'', il 7 settembre a Bologna
31/08/2016
Electro Camp – International Platform for New Sounds and Dance, a Forte Marghera dal 7 all'11 settembre
APPROFONDIMENTI, EDITORIALI, COMMENTI > Suggestioni e magnetismo della scena contemporanea
Non ci sono frontiere tra la coreografia,
il fatto di danzare e quello di vivere;
il gesto è bello soltanto
se motivato dalla verità interiore
(Carolyn Carlson)
Si tratta di punti di vista, linguaggi possibili, interrogativi che il Festival ha scelto di presentare nella sua quinta edizione. Si comincia con l'insolito connubio italo-francese del Teatro delle Ariette e del Théatre de Chambre, passando dal lavoro solitario del giapponese Hiroaki Umeda per finire con la poesia di Raffaella Giordano e con l’esplosiva coreografia della danese Mette Ingvartsen. Artisti che non lasciano indifferenti, che lavorano sui diversi elementi della scena come artigiani all’opera, utilizzando talvolta strumenti più rudimentali, come nel caso del Teatro delle Ariette, oppure dando vita a sofisticate macchine teatrali, come nel caso del coreografo giapponese Hiroaki Umeda. Se quest’ultimo, in Duo, sceglie di mantenere una distanza fisica e reale con il pubblico, per eventualmente riavvicinarlo e sconcertarlo con l’uso di avanzati mezzi tecnologici, Paola Berselli e Stefano Pasquini, fondatori della compagnia bolognese e protagonisti del progetto Dans ma Maison (conte de la vie ordinaire) – Episodio 2 Italie, in collaborazione con il Théatre de Chambre, scelgono un’intimità che incanta. Lo sguardo vigile degli spettatori, che circondano la “magica” scatola di legno in cui si svolge l’azione teatrale, è qui particolarmente vicino. Nel microcosmo costruito in collaborazione con il Théâtre de Chambre, la giornata trascorre tranquilla. Sembra una storia d’altri tempi, di uomini e donne capaci di incantarsi davanti a un fiore che sboccia o un nuovo giorno che inizia. La regia di Christophe Piret racconta di una casa lontana, di una cucina in cui si preparano le tigelle per i vicini di casa, di un caldo focolare domestico. Tutto appare in miniatura, dentro un ambiente in apparenza un po’ claustrofobico: gli ingranaggi tecnici rivelano scale di legno che consentono gli spostamenti tra il piano terra e l’area rialzata, botole sotterranee e un pozzo d’acqua. C’è molta cura. Nei gesti e nel linguaggio, nel misurare le azioni e le parole. I protagonisti si mostrano per quello che sono e i valori in cui credono. A tratti sembra di guardare dal buco di una serratura, da cui qualcosa è solo intravisto. Gli odori sono forti, riportano in campagna, dove l’erba è ormai ingiallita ma il cuore ha voglia di emozionarsi.
Emozioni che a Prato volano alte anche per Raffaella Giordano e i suoi interpreti, sei attori, che con Cuocere il mondo lasciano un’impronta particolarmente lacerata, di un viaggio compiuto, tra i silenzi e i vuoti, tra la lentezza e lo sfaldamento, e ricordano, secondo le parole della coreografa, che «un singolo gesto custodisce un miracolo di essenza». Appaiono come anime perse, vaganti, tra le pieghe di un deserto inaridito. Corpi raggelati e silenziosi, ricoperti da brandelli di vita e riscaldati dalla purezza dell’anima. Anime che insieme al corpo si fanno presenza, morte e resurrezione. Racconta Giordano, «Ci siamo avvicinati all’episodio dell’Ultima Cena, nella dinamica dell’evento rappresentata dal dipinto di Leonardo. Abbiamo attraversato un silenzio ed un tempo preziosi, lasciando che l’intreccio dei nostri cuori svelasse le tracce da seguire e il sentiero da sostenere». Il cuore della Giordano è “trafitto” e i suoi passi solcano il terreno, per poi incontrare lo spettatore nell’immagine finale dello spettacolo: tutti gli interpreti si mettono in ascolto, sedendosi a semicerchio, rivolti verso la platea. Mantiene delicatamente la distanza, questa donna matura, in apparenza particolarmente fragile, che non si lascia scivolare nulla addosso, ma al contrario sembra portare con sé, o meglio trascinare, il fardello di una riflessione profonda.
La distesa di sabbia può però germogliare, come succede in Why we love action, della coreografa ventisettenne Mette Ingvartsen. Su una scena completamente verdeggiante, magnetismo e seduzione non si distinguono più. È un susseguirsi di scene bulimiche, eccessive e irrefrenabili, in cui si respira una spensierata giovinezza e, a tratti, un’ingenua impulsività, che travalicano lo spazio scenico per giungere inermi su un terreno dal contrassegno cinematografico. La vitalità della coreografa danese, che fa ridere, combattere e piangere i suoi danzatori, buca la quarta parete per lasciare fluire un’energia che addirittura raddoppia e rasenta l’effetto del cinema d’azione, facendo del corpo in movimento, in quanto oggetto di fascino e seduzione, l’elemento primario. Si rivolge allo studio del cambiamento di prospettiva e di percezione del corpo con differenti inquadrature rappresentative, non tanto per disorientare lo sguardo quanto piuttosto per esplorare varie strategie di approccio alla coreografia. Capelli rossi e aria sbarazzina, questa giovane allieva di P.A.R.T.S. (The Performing Arts Research and Training Studios - scuola diretta dalla coreografa belga Anne Teresa De Keersmaeker), utilizza una scena concettuale per dare risalto alla fisicità dei danzatori e veste di humour e noir corpi perfettamente allenati e malleabili.
Forza e debolezza sembrano essere le parole chiave che in qualche modo accomunano la Ingvartsen agli altri coreografi ospiti a Contemporanea 07. Non importa quanto il mondo rappresentato sia reale o virtuale o surreale, quanto il gioco si faccia più o meno duro, quanto il pubblico venga intimidito o rassicurato, perché resta una certezza che mette in relazione anche i lavori apparentemente più discordanti, il fatto di assistere a un atto vero e meditato, per quanto possa diventare astratto e sminuzzato nel suo stesso farsi. Un atto che vive nel momento in cui si compie ma porta con sé un’emozione più grande, quella che ogni artista cerca in se stesso per trasmetterla in chi guarda. Come ci ricorda Dominique Dupuy, «Credo di aver scelto la danza perché amo profondamente trovarmi sulla scena. L'occhio dello spettatore è una delle componenti della danza. Gli dà verità di esistenza. Il danzatore dovrebbe sempre tener presente questo, non solo quando è in scena, ma anche nel lavoro preparatorio. La sensazione di essere guardati fa uscire la danza da una meccanica corporale e genera uno stato del corpo propizio alla verità poetica». Una condizione di danzatore, questa, che dovrebbe valere per chiunque faccia delle arti della scena la propria ragione di vita.
Emozioni che a Prato volano alte anche per Raffaella Giordano e i suoi interpreti, sei attori, che con Cuocere il mondo lasciano un’impronta particolarmente lacerata, di un viaggio compiuto, tra i silenzi e i vuoti, tra la lentezza e lo sfaldamento, e ricordano, secondo le parole della coreografa, che «un singolo gesto custodisce un miracolo di essenza». Appaiono come anime perse, vaganti, tra le pieghe di un deserto inaridito. Corpi raggelati e silenziosi, ricoperti da brandelli di vita e riscaldati dalla purezza dell’anima. Anime che insieme al corpo si fanno presenza, morte e resurrezione. Racconta Giordano, «Ci siamo avvicinati all’episodio dell’Ultima Cena, nella dinamica dell’evento rappresentata dal dipinto di Leonardo. Abbiamo attraversato un silenzio ed un tempo preziosi, lasciando che l’intreccio dei nostri cuori svelasse le tracce da seguire e il sentiero da sostenere». Il cuore della Giordano è “trafitto” e i suoi passi solcano il terreno, per poi incontrare lo spettatore nell’immagine finale dello spettacolo: tutti gli interpreti si mettono in ascolto, sedendosi a semicerchio, rivolti verso la platea. Mantiene delicatamente la distanza, questa donna matura, in apparenza particolarmente fragile, che non si lascia scivolare nulla addosso, ma al contrario sembra portare con sé, o meglio trascinare, il fardello di una riflessione profonda.
La distesa di sabbia può però germogliare, come succede in Why we love action, della coreografa ventisettenne Mette Ingvartsen. Su una scena completamente verdeggiante, magnetismo e seduzione non si distinguono più. È un susseguirsi di scene bulimiche, eccessive e irrefrenabili, in cui si respira una spensierata giovinezza e, a tratti, un’ingenua impulsività, che travalicano lo spazio scenico per giungere inermi su un terreno dal contrassegno cinematografico. La vitalità della coreografa danese, che fa ridere, combattere e piangere i suoi danzatori, buca la quarta parete per lasciare fluire un’energia che addirittura raddoppia e rasenta l’effetto del cinema d’azione, facendo del corpo in movimento, in quanto oggetto di fascino e seduzione, l’elemento primario. Si rivolge allo studio del cambiamento di prospettiva e di percezione del corpo con differenti inquadrature rappresentative, non tanto per disorientare lo sguardo quanto piuttosto per esplorare varie strategie di approccio alla coreografia. Capelli rossi e aria sbarazzina, questa giovane allieva di P.A.R.T.S. (The Performing Arts Research and Training Studios - scuola diretta dalla coreografa belga Anne Teresa De Keersmaeker), utilizza una scena concettuale per dare risalto alla fisicità dei danzatori e veste di humour e noir corpi perfettamente allenati e malleabili.
Forza e debolezza sembrano essere le parole chiave che in qualche modo accomunano la Ingvartsen agli altri coreografi ospiti a Contemporanea 07. Non importa quanto il mondo rappresentato sia reale o virtuale o surreale, quanto il gioco si faccia più o meno duro, quanto il pubblico venga intimidito o rassicurato, perché resta una certezza che mette in relazione anche i lavori apparentemente più discordanti, il fatto di assistere a un atto vero e meditato, per quanto possa diventare astratto e sminuzzato nel suo stesso farsi. Un atto che vive nel momento in cui si compie ma porta con sé un’emozione più grande, quella che ogni artista cerca in se stesso per trasmetterla in chi guarda. Come ci ricorda Dominique Dupuy, «Credo di aver scelto la danza perché amo profondamente trovarmi sulla scena. L'occhio dello spettatore è una delle componenti della danza. Gli dà verità di esistenza. Il danzatore dovrebbe sempre tener presente questo, non solo quando è in scena, ma anche nel lavoro preparatorio. La sensazione di essere guardati fa uscire la danza da una meccanica corporale e genera uno stato del corpo propizio alla verità poetica». Una condizione di danzatore, questa, che dovrebbe valere per chiunque faccia delle arti della scena la propria ragione di vita.
COMPAGNIE
AGENDA
18 luglio 2018
Sansepolcro, Kilowatt Festival
A Porte Aperte. Un convegno sui processi creativi tra sguardi, ricerche, residenze
30 maggio 2018
Bologna
Presentazione cd audio Crescere spettatori
18 luglio 2018
Sansepolcro, Kilowatt Festival
A Porte Aperte. Un convegno sui processi creativi tra sguardi, ricerche, residenze
30 maggio 2018
Bologna
Presentazione cd audio Crescere spettatori
TEATRI D'OGGI
Baci dalla provincia
Note, appunti, cronache, recensioni sulla scena teatrale italiana e internazionale
Interviste
Conversazioni sulla scena contemporanea italiana e internazionale
La qualita' dell'aria
Approfondimenti, riflessioni, spunti: questioni che ci stanno a cuore partendo dalle opere per arrivare ai "teatri", e che vorremmo condividere
Scritture, drammaturgie
Note, appunti, percorsi sul panorama editoriale attento alle arti sceniche
Radio
Raccogliamo in questa sezione alcune delle puntate radiofoniche dal vivo curate da Altre Velocità
Doppiozero - Teatri presenti
Approfondimenti, ritratti, recensioni, interviste per Doppiozero, rivista diretta da Marco Belpoliti. In questo spazio raccogliamo gli articoli a un mese di distanza dalla loro uscita
La parola attore
Cosa chiediamo a un attore, a una attrice? Cosa chiedono loro a noi? Scritti d'attore e di attrici originali per Altre Velocità
Baci dalla provincia
Note, appunti, cronache, recensioni sulla scena teatrale italiana e internazionale
Interviste
Conversazioni sulla scena contemporanea italiana e internazionale
La qualita' dell'aria
Approfondimenti, riflessioni, spunti: questioni che ci stanno a cuore partendo dalle opere per arrivare ai "teatri", e che vorremmo condividere
Scritture, drammaturgie
Note, appunti, percorsi sul panorama editoriale attento alle arti sceniche
Radio
Raccogliamo in questa sezione alcune delle puntate radiofoniche dal vivo curate da Altre Velocità
Doppiozero - Teatri presenti
Approfondimenti, ritratti, recensioni, interviste per Doppiozero, rivista diretta da Marco Belpoliti. In questo spazio raccogliamo gli articoli a un mese di distanza dalla loro uscita
La parola attore
Cosa chiediamo a un attore, a una attrice? Cosa chiedono loro a noi? Scritti d'attore e di attrici originali per Altre Velocità
FESTIVAL
marzo-maggio 2018
Planetarium
Osservatorio sul teatro ragazzi
14 - 22 ottobre 2017
Vie Festival 2017
Laboratorio di critica e giornalismo
giugno 2017
Futuri Maestri
Laboratorio Futuri giornalisti
28-31 ottobre 2016
Crisalide
Perché passi un po' di caos libero e ventoso
ottobre 2016
Vie Festival 2016
Arti sceniche internazionali e italiane
22 settembre - 2 ottobre 2016
Contemporanea Festival 2016
Le arti della scena
ottobre 2015
Vie Festival 2015
Arti sceniche internazionali e italiane
1-4 ottobre 2015
Crisalide
Non è successo niente, è ciò che stiamo diventando
25 settembre - 4 ottobre 2015
Contemporanea Festival 2015
Le arti della scena
Febbraio - aprile 2015
Nelle pieghe del Corpo
Virgilio Sieni, Bologna
ottobre 2014 - marzo 2015
Festival Focus Jelinek
Festival per città
9-25 ottobre 2014
Vie Festival 2014 Modena___Emilia
Arti sceniche internazionali
10 - 20 luglio 2014
Santarcangelo · 14
Festival internazionale del teatro in piazza
12 - 21 luglio 2013
Santarcangelo · 13
Festival Internazionale del Teatro in Piazza
aprile 2013
Pinocchio della non-scuola
Immagini a cura di Osservatorio Fotografico, note a margine su Pinocchio
5-13 ottobre 2012
Tempo Reale Festival
Ricerche musicali contemporanee
14 - 23 luglio 2012
SANTARCANGELO •12
Festival internazionale del teatro in piazza
Primavera 2012
Vie Scena Contemporanea Festival
Arti sceniche internazionali
Marzo 2012
BilBolbul 2012
fumetto, illustrazione, disegno
ottobre 2011
Vie Scena Contemporanea Festival
Teatro internazionale a Modena, Carpi, Vignola e limitrofi
Settembre 2011
Arca Puccini - Musica per combinazione
Rock indipendente italiano e internazionale
marzo-maggio 2018
Planetarium
Osservatorio sul teatro ragazzi
14 - 22 ottobre 2017
Vie Festival 2017
Laboratorio di critica e giornalismo
giugno 2017
Futuri Maestri
Laboratorio Futuri giornalisti
28-31 ottobre 2016
Crisalide
Perché passi un po' di caos libero e ventoso
ottobre 2016
Vie Festival 2016
Arti sceniche internazionali e italiane
22 settembre - 2 ottobre 2016
Contemporanea Festival 2016
Le arti della scena
ottobre 2015
Vie Festival 2015
Arti sceniche internazionali e italiane
1-4 ottobre 2015
Crisalide
Non è successo niente, è ciò che stiamo diventando
25 settembre - 4 ottobre 2015
Contemporanea Festival 2015
Le arti della scena
Febbraio - aprile 2015
Nelle pieghe del Corpo
Virgilio Sieni, Bologna
ottobre 2014 - marzo 2015
Festival Focus Jelinek
Festival per città
9-25 ottobre 2014
Vie Festival 2014 Modena___Emilia
Arti sceniche internazionali
10 - 20 luglio 2014
Santarcangelo · 14
Festival internazionale del teatro in piazza
12 - 21 luglio 2013
Santarcangelo · 13
Festival Internazionale del Teatro in Piazza
aprile 2013
Pinocchio della non-scuola
Immagini a cura di Osservatorio Fotografico, note a margine su Pinocchio
5-13 ottobre 2012
Tempo Reale Festival
Ricerche musicali contemporanee
14 - 23 luglio 2012
SANTARCANGELO •12
Festival internazionale del teatro in piazza
Primavera 2012
Vie Scena Contemporanea Festival
Arti sceniche internazionali
Marzo 2012
BilBolbul 2012
fumetto, illustrazione, disegno
ottobre 2011
Vie Scena Contemporanea Festival
Teatro internazionale a Modena, Carpi, Vignola e limitrofi
Settembre 2011
Arca Puccini - Musica per combinazione
Rock indipendente italiano e internazionale
PODCAST
febbraio 2015
Radio Zolfo - Rafael Spregelburd
Con Rafael Spregelburd e Silvia Mei
febbraio 2015
Radio Zolfo - Interpretare Elfriede Jelinek
con Elena Bucci Fiorenza Menni / Ateliersi Anna Amadori e Olga Durano / Teatri di Vita e con Elena Di Gioia
maggio 2013
Radio Zolfo #festa13
Con Cristina D'Alberto, Marco Valerio Amico, Chiara Lagani. Showcase di Mangiacassette
aprile 2013
Radio Zolfo Focus Melquiot
Con Anna Amadori, showcase di Guido Sodo
febbraio 2015
Radio Zolfo - Rafael Spregelburd
Con Rafael Spregelburd e Silvia Mei
febbraio 2015
Radio Zolfo - Interpretare Elfriede Jelinek
con Elena Bucci Fiorenza Menni / Ateliersi Anna Amadori e Olga Durano / Teatri di Vita e con Elena Di Gioia
maggio 2013
Radio Zolfo #festa13
Con Cristina D'Alberto, Marco Valerio Amico, Chiara Lagani. Showcase di Mangiacassette
aprile 2013
Radio Zolfo Focus Melquiot
Con Anna Amadori, showcase di Guido Sodo
PUBBLICAZIONI
2012
Barokthegreat, Gli Incauti, Menoventi, Orthographe
CODA - Teatri del presente
2010
Disegni e parole dal teatro di Fanny & Alexander, Motus, Chiara Guidi/Societas Raffaello Sanzio, Teatrino Clandestino
UN COLPO
2009
Azione e immaginazione da Cantieri a Anticorpi XL
Giovane Danza d'Autore
2012
Barokthegreat, Gli Incauti, Menoventi, Orthographe
CODA - Teatri del presente
2010
Disegni e parole dal teatro di Fanny & Alexander, Motus, Chiara Guidi/Societas Raffaello Sanzio, Teatrino Clandestino
UN COLPO
2009
Azione e immaginazione da Cantieri a Anticorpi XL
Giovane Danza d'Autore