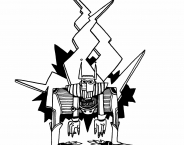26/04/2018
Osservatorio sul festival Ipercorpo: aperte le iscrizioni
20/03/2018
Direction Under 30: aperto il bando per candidarsi
20/03/2018
Planetarium ai festival di teatro-ragazzi
19/03/2018
Teatro e giovani generazioni: un incontro-dibattito a Castelfiorentino
10/11/2017
Performing Gender: gran finale a Bologna
08/11/2017
Master in Imprenditoria dello spettacolo 17-18, Università di Bologna
07/11/2017
Con occhi nudi: un itinerario al femminile
05/11/2017
Lettera 22. Premio giornalistico nazionale di critica teatrale under 36
04/09/2017
Cornice Aperta. Aperitivo con gli artisti del Festival Danza Urbana
19/05/2017
Maggio all'infanzia, dal 17 al 21 maggio a Bari
04/05/2017
Ivrea Cinquanta – Mezzo secolo di Nuovo Teatro in Italia 1967 – 2017. Genova, 5-7 maggio
29/03/2017
Un teatro in mezzo ai campi: 8 aprile con le Ariette
24/03/2017
''La formazione del nuovo pubblico'': un convegno sabato 25 marzo ad Albenga
28/02/2017
“Comizi d’amore”, open call per registi/drammaturghi e attori under 35 di Kepler-452
11/01/2017
La cultura nell'economia italiana: il 13 gennaio un convegno a Bologna
05/12/2016
Impertinente Festival: il teatro di figura a Parma, dal 7 all'11 dicembre
07/10/2016
Master in imprenditoria dello spettacolo, Bologna, anno accademico 2016-2017
23/09/2016
Infanzia e città a Pistoia, dal 24 settembre al 5 novembre 2016
03/09/2016
Dalla Cultura alla Scuola: ''Cosa abbiamo in Comune'', il 7 settembre a Bologna
31/08/2016
Electro Camp – International Platform for New Sounds and Dance, a Forte Marghera dal 7 all'11 settembre
Claudio Longhi, docente al Dams di Bologna, regista e studioso, insieme a Elena di Gioia ha curato per il Festival la giornata di studi e performance del 3 dicembre 2014, denominata Happening Jelinek, e contemporaneamente ha condotto un laboratorio attorno all'ultimo testo della scrittrice austriaca che si concluderà sempre il 3 con una mise en espace. Lo abbiamo incontrato.
Per cominciare, le chiederei come nasce la collaborazione con Elena Di Gioia e come si è sviluppato nel tempo il progetto su Elfriede Jelinek che ha dato origine all'Happening Jelinek.
Elena aveva giustamente cercato un'interlocuzione con Gerardo Guccini che è il punto di riferimento sul piano della ricerca drammaturgica del nostro Dipartimento e il Responsabile scientifico del Centro Cimes. Sulla base di una loro chiacchierata precedente, Gerardo mi ha chiesto se ero interessato a curare una costola della prossima stagione del Cimes che avrebbe dovuto segnare l'incontro tra il progetto Jelinek di Elena e l'attività di ricerca applicata dell'università. La cosa mi ha fatto molto piacere perché, da anni, avevo una certa curiosità nei confronti della scrittura dell'autrice. Quindi, quando la proposta è arrivata, ovviamente, l'ho accolta anche perché esisteva un rapporto precedente con Elena, fatto di conversazioni, scambi mail e anche di attenzione e interesse rispetto a un modo altro di pensare il teatro all'interno di un “territorio di riferimento” – mi si passi per comodità espositiva l’espressione, che pure non amo.
La formula Happening Jelinek non è semplicemente un arzigogolo onomastico, ma la cifra di un modo di impostare una riflessione. Il convegno a cui stiamo ponendo mano, infatti, non raccoglie soltanto studiosi, ma anche artisti e vuole essere una sorta di tuffo nell'universo Jelinek, nella scrittura dell’autrice, a 360°, un tuffo che, anche nelle sue modalità di organizzazione, mette insieme due momenti: concettuale e “perfomativo”. Il progetto, infatti, ha due parallele ragioni di interesse. Per un verso, vi si riscontra un’attenzione tematica per l'autrice di cui stiamo parlando e per il suo universo composito tra ideologia e post-ideologia, tra drammatico e postdrammatico. D'altra parte, si tratta di un festival che si spalma su una regione e che, quindi, pone alcuni problemi rispetto ad un determinato rapporto del pubblico con l'oggetto proposto, in un arco temporale e in un ambito territoriale piuttosto vasto. Bologna sarà una sorta di ombelico meta-progettuale: con l’Happening Jelinek, infatti, il progetto riflette su se stesso, attraverso protagonisti che si incontrano e possono confrontarsi. Poi, ci sarà l'appendice del laboratorio, nata proprio a partire dalla natura anfibia della giornata.
Come avete pensato di strutturare il percorso laboratoriale?
Il laboratorio è stato un ulteriore incentivo al mio coinvolgimento. Nel caso del progetto Jelinek, mi si è proposta un'occasione “ghiotta”: uno degli ultimi copioni, se non l'ultimo, della Jelinek è stato presentato in anteprima a maggio e, credo, da poco ha debuttato in versione definitiva in Germania. Il titolo è Die Schutzbefohlenen ed è una sorta di travestimento, mascheratura, rifacimento delle Supplici di Eschilo. Questa ripresa di elementi classici è un tratto tipico della scrittura dell'autrice. È un testo in cui, come capita in Sport o in Bambiland, la Jelinek intreccia il piano del mito a quello della contemporaneità. Il tema – se di tema si può parlare – è quello dell'emigrazione ed è un testo scritto anche sull'onda delle suggestioni del naufragio di Lampedusa di ottobre. L’idea del laboratorio è nata anche dal fatto che uno dei maggiori studiosi della Jelinek in Italia, il suo traduttore, Luigi Reitani, ha manifestato un certo interesse nei confronti di questo testo. Sarà un laboratorio di una settimana, su una scrittura molto complessa, che vedrà un lavoro intorno al copione; l’esito – ovviamente non stiamo parlando di una messa in scena in senso stretto – sarà presentato la sera dell'Happenning Jelinek a completare l'attraversamento.
Parliamo, quindi, di drammaturgia. L'impressione che ho avuto rispetto alla scrittura della Jelinek, per il teatro e non solo, è che sia piena, complessa, autonoma. Eppure, pone due ordini di problemi: il primo è un problema di rappresentabilità, il secondo di leggibilità.
Concordo completamente rispetto alla sensazione di autonomia. L’impressione che ho è che la scrittura della Jelinek abbini una specie di assoluta superficialità e una fortissima tridimensionalità. È come se, paradossalmente, fosse una scrittura impalpabile e ramificata in un gioco di slittamenti continui che mi ricorda la musica di Steve Reich, con delle cellule che ne generano incessantemente altre in una specie di moto perpetuo di sviluppo. Dall'altra parte, però, questa superficie infinita ha una sorta di violenta profondità che deriva dal gioco continuo di rimandi, di recuperi di scritture altre. Sia in questa sorta di tridimensionalità seduta, sia in questa sorta di vertiginosa verticalità, la scrittura tende ad autonomizzarsi rispetto a un'ipotesi di rappresentazione.
Detto questo, voglio aggiungere due considerazioni a margine: per un verso, credo di essere la persona meno indicata a parlare di problemi di definizione di coefficienti di teatralità perché, nella mia esperienza passata, ho una tappa di formazione che continua a rimanere imprescindibile, ossia la collaborazione con Ronconi e Ronconi ha sempre sostenuto che in teatro si possa mettere in scena anche l'elenco del telefono. Per un altro verso, il problema successivo riguarda la nozione di teatralità. È chiaro che se per “teatrale” intendiamo tutto quello che per secoli abbiamo associato alla nozione di drammaturgia, quell'idea con il teatro della Jelinek non ha assolutamente nulla a che spartire. Se, invece, collochiamo la nostra indagine nel contesto della cosiddetta postdrammaturgia, le cose cambiano immediatamente. Mi viene in mente la posizione della Stein che paragona la scrittura drammatica a un paesaggio in cui la teatralità sta nella relazione che esiste tra due alberi all'interno dello stesso scorcio e non necessariamente tra una figura A e una figura B che si scontrano l'una con l'altra. Letta in questa direzione, una scrittura densa come quella della Jelinek acquista delle risorse di fortissima teatralità di tipo relazionale.
Eppure, mi chiedo se in questa tridimensionalità non ci sia una fortissima tensione drammatica e intendo il drammatico nel suo senso puro, come una tensione di sviluppo, fosse anche solo nello stile. Sono paesaggi, non macchine narrative, ma in evoluzione continua, in tensione.
Indiscutibilmente. Quando la Stein riflette sulla pièce-paesaggio il punto di partenza, se non ricordo male, è la percezione di nervosismo che si ha a teatro per la natura sincopata della relazione che si dà tra lo spettacolo e lo spettatore. Quest’ultimo si sente infatti sempre in anticipo o in ritardo rispetto a quello che sta succedendo in scena. È questo un altro modo per parlare di quella tensione verso l'esito che, universalmente, a partire da una certa riflessione romantica in poi, ma sulla base di presupposti aristotelici, è stata riconosciuta come definizione del teatrale. Questa tensione, in scritture come quelle della Jelinek, non è tanto presente dal punto di vista della struttura narrativa, della conflittualità tra personaggi, ma esiste sul piano della scrittura, del rapporto tra le parole. È probabilmente questa tensione lessicale e sintattica la scaturigine della teatralità della scrittura della Jelinek.
18 luglio 2018
Sansepolcro, Kilowatt Festival
A Porte Aperte. Un convegno sui processi creativi tra sguardi, ricerche, residenze
30 maggio 2018
Bologna
Presentazione cd audio Crescere spettatori
Baci dalla provincia
Note, appunti, cronache, recensioni sulla scena teatrale italiana e internazionale
Interviste
Conversazioni sulla scena contemporanea italiana e internazionale
La qualita' dell'aria
Approfondimenti, riflessioni, spunti: questioni che ci stanno a cuore partendo dalle opere per arrivare ai "teatri", e che vorremmo condividere
Scritture, drammaturgie
Note, appunti, percorsi sul panorama editoriale attento alle arti sceniche
Radio
Raccogliamo in questa sezione alcune delle puntate radiofoniche dal vivo curate da Altre Velocità
Doppiozero - Teatri presenti
Approfondimenti, ritratti, recensioni, interviste per Doppiozero, rivista diretta da Marco Belpoliti. In questo spazio raccogliamo gli articoli a un mese di distanza dalla loro uscita
La parola attore
Cosa chiediamo a un attore, a una attrice? Cosa chiedono loro a noi? Scritti d'attore e di attrici originali per Altre Velocità
marzo-maggio 2018
Planetarium
Osservatorio sul teatro ragazzi
14 - 22 ottobre 2017
Vie Festival 2017
Laboratorio di critica e giornalismo
giugno 2017
Futuri Maestri
Laboratorio Futuri giornalisti
28-31 ottobre 2016
Crisalide
Perché passi un po' di caos libero e ventoso
ottobre 2016
Vie Festival 2016
Arti sceniche internazionali e italiane
22 settembre - 2 ottobre 2016
Contemporanea Festival 2016
Le arti della scena
ottobre 2015
Vie Festival 2015
Arti sceniche internazionali e italiane
1-4 ottobre 2015
Crisalide
Non è successo niente, è ciò che stiamo diventando
25 settembre - 4 ottobre 2015
Contemporanea Festival 2015
Le arti della scena
Febbraio - aprile 2015
Nelle pieghe del Corpo
Virgilio Sieni, Bologna
ottobre 2014 - marzo 2015
Festival Focus Jelinek
Festival per città
9-25 ottobre 2014
Vie Festival 2014 Modena___Emilia
Arti sceniche internazionali
10 - 20 luglio 2014
Santarcangelo · 14
Festival internazionale del teatro in piazza
12 - 21 luglio 2013
Santarcangelo · 13
Festival Internazionale del Teatro in Piazza
aprile 2013
Pinocchio della non-scuola
Immagini a cura di Osservatorio Fotografico, note a margine su Pinocchio
5-13 ottobre 2012
Tempo Reale Festival
Ricerche musicali contemporanee
14 - 23 luglio 2012
SANTARCANGELO •12
Festival internazionale del teatro in piazza
Primavera 2012
Vie Scena Contemporanea Festival
Arti sceniche internazionali
Marzo 2012
BilBolbul 2012
fumetto, illustrazione, disegno
ottobre 2011
Vie Scena Contemporanea Festival
Teatro internazionale a Modena, Carpi, Vignola e limitrofi
Settembre 2011
Arca Puccini - Musica per combinazione
Rock indipendente italiano e internazionale
febbraio 2015
Radio Zolfo - Rafael Spregelburd
Con Rafael Spregelburd e Silvia Mei
febbraio 2015
Radio Zolfo - Interpretare Elfriede Jelinek
con Elena Bucci Fiorenza Menni / Ateliersi Anna Amadori e Olga Durano / Teatri di Vita e con Elena Di Gioia
maggio 2013
Radio Zolfo #festa13
Con Cristina D'Alberto, Marco Valerio Amico, Chiara Lagani. Showcase di Mangiacassette
aprile 2013
Radio Zolfo Focus Melquiot
Con Anna Amadori, showcase di Guido Sodo
2012
Barokthegreat, Gli Incauti, Menoventi, Orthographe
CODA - Teatri del presente
2010
Disegni e parole dal teatro di Fanny & Alexander, Motus, Chiara Guidi/Societas Raffaello Sanzio, Teatrino Clandestino
UN COLPO
2009
Azione e immaginazione da Cantieri a Anticorpi XL
Giovane Danza d'Autore